Relazione di Alain De Benoist
Rimini

molto probabilmente intorno al 15 febbraio, un diluvio di ferro e fuoco si abbatterà sul popolo iracheno. Perché vada diversamente, ci vorrebbe un vero miracolo: mai una guerra dei tempi moderni sarà stata così chiaramente annunciata. 70.000 uomini sono già sul posto, altri 50.000 li devono raggiungere nei giorni a venire. La macchina di guerra americana si prepara evidentemente a produrre una guerra che viene disapprovata senza ambiguità da 3/4 della popolazione europea e francese, un biasimo che si spiega soprattutto per il carattere menzognero dei motivi adotti per giustificare questa operazione.
L’Iraq, piccolo paese di 24 milioni di abitanti, non minaccia oggi in realtà nessuno. Ne sarebbe comunque in grado. I bombardamenti che ha subìto hanno fatto più di 200.000 vittime nel 1991. La quasi totalità dell’industria irachena è stata distrutta. Innumerevoli scuole, asili e ospedali sono stati rasati al suolo. L’embargo ha poi impedito all’Iraq di ricostruirsi. Ha provocato la morte, soprattutto per malnutrizione, di un mezzo milione di iracheni, in gran parte bambini.
In questo paese devastato dalla guerra e dall’embargo, l’ONU ha fatto eseguire nel giro di otto anni oltre 13.500 ispezioni in seguito alle quali qualunque impianto, che avrebbe ancora potuto permettere di produrre delle armi, è stato distrutto. L’Iraq è stato bombardato regolarmente. La sua popolazione è minata da malattie e carenze alimentari. Le sue forze militari rappresentano appena il terzo di quello che erano nel 1991. Sarebbe molto sorprendente, in queste condizioni, che possedesse “armi di distruzione di massa”, e più sorprendente ancora che avesse l’intenzione di impiegarle.
All’Iraq è stato ingiunto di provare di non essere in possesso di tali armi. Ma tutti sanno che non è possibile fornire la prova che non esistano. Gli Stati Uniti hanno quindi in realtà racchiuso l’Iraq in una situazione di “doppio vincolo” (double bind), cioè in una situazione che vede Iraq automaticamente perdente: le si farà comunque la guerra, o perché sarà stato dimostrato che possiede armi di distruzione di massa o perché non avrà potuto dimostrare di non possederne! Quanto agli Stati Uniti, che possiedono essi stessi il più importante stock planetario di armi di distruzione di massa, e che non hanno cessato di farne uso, nessuno si sogna, a quanto pare, di pretendere da loro la stessa prova. Come curiosamente ha dichiarato Richard Perle, Presidente del Consiglio delle Politiche di Difese del Pentagono, “gli ispettori potranno sempre dire di non avere trovato niente, ma non potranno mai dire che non ci fosse niente da trovare”.
Le armi di distruzione di cui l’Iraq ha potuto disporre in passato, sono ben note agli occidentali, in quanto sono stati loro stessi a fornirle. Ricordiamoci che proprio Jacques Chirac, allora Primo Ministro, ha permesso a Saddam Hussein di visitare nel luglio 1975 le installazioni atomiche francesi della Valle del Rodano, Quattro mesi dopo, in novembre, Parigi forniva a Bagdad prima una, poi due centrali nucleari. Gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e la Germania non furono da meno. Negli anni ’80 sono stati gli Americani che hanno incoraggiato l’Iraq ad attaccare l’Iran, fornendogli le informazioni raccolte via satellite. Sono stati loro, in seguito, che hanno fornito al regime di Bagdad tutte le armi di cui avessero bisogno per fare la guerra a Teheran, con la speranza che questo conflitto, che ha fatto più di un milione di vittime, avrebbe indebolito simultaneamente le due nazioni in conflitto.
Neanche la lotta contro il terrorismo ha niente a che vedere con la guerra contro l’Iraq. D’altra parte sono gli Americani stessi che, nel 1984, avevano cancellato l’Iraq dalla lista dei paesi che sostenevano il terrorismo. L’Iraq, paese laico, è probabilmente oggi l’unico paese arabo a non avere alcun legame con le reti terroristiche islamiche.
Quindici dei 19 presunti autori degli attenti dell’11 settembre erano sauditi. Nessuno di loro era iracheno.
Questa guerra, infine, è totalmente ingiustificata dal punto di vista del Diritto Internazionale. L’articolo 2 della Carta delle Nazioni Unite vieta in effetti di “impiegare la forza o di minacciare l’integrità territoriale oppure l’indipendenza politica di qualunque paese”. Gli articoli 41 e 42 sanciscono altrettanto che nessuno Stato Membro abbia il diritto di attaccarne un altro e neanche di impiegare la forza per fare applicare una risoluzione senza l’accordo esplicito del Consiglio di Sicurezza. Ne consegue che gli attacchi perpetrati dal 1991 contro l’Iraq sono in realtà illegali dal punto di vista del Diritto Internazionale.
La maggioranza dei paesi del mondo, a cominciare dai paesi vicini all’Iraq e anche da alcuni paesi alleati di Washington, hanno avvisato gli Americani che scatenando una nuova guerra contro Bagdad avrebbero rischiato di aprire il vaso di Pandora, di destabilizzare tutto il Medio Oriente, di provocare una nuova ondata di terrorismo. Ma invano.
A quanto pare niente potrà rallentare la cieca fuga in avanti della macchina di guerra americana. Qualunque sia l’atteggiamento di Bagdad, qualunque siano le conclusioni degli ispettori dell’ONU la macchina è in azione. Alcuni piani di occupazione dell’Iraq, in gran parte ripresi dal modello del piano di occupazione del Giappone – messo in atto nel 1945 dal generale Douglas MacArthur – sono già stati interrotti.
Perché un tale accanimento? I motivi sembrano essere molteplici. Attaccando l’Iraq, gli Stati Uniti vogliono evidentemente favorire gli interessi dei loro alleati Israeliani. Loro ambiscono ad un rimodellamento completo della regione più conforme ai propri interessi. Ma la ragione principale della loro politica belligerante è estremamente concreta. La ragione è il petrolio.
Il petrolio rappresenta oggi il 40% del consumo di energia totale nel mondo. E questo peso è destinato ad aumentare, dato che l’esigenza mondiale, che è passata tra il 1973 e il 2002 da 57 a 75 milioni di barili al giorno, dovrebbe ancora crescere del 50% nel corso dei prossimi venti anni. Gli Stati Uniti, che nel 1929 garantivano oltre i 3/4 della produzione del petrolio, sono diventati importatori nel 1948. Allo stato attuale, nonostante rappresentino solo il 5% della popolazione mondiale, gli Americani assorbono oltre 1/4 del consumo mondiale, mentre la loro stessa produzione non cessa di diminuire. Nel 2020 il loro bisogno di petrolio importato arriverà al 66% del totale del loro consumo, contro il 44,6% nel 1997 e il 53% del 2000. é per loro quindi vitale assicurarsi nuovi sbocchi e, parallelamente, poter diversificare i loro rifornimenti.
Tale è precisamente l’obiettivo che l’attuale amministrazione americana si è prefissa con l’elezione di G.W. Bush. Pubblicato nel maggio del 2001, un documento redatto dall’attuale vice presidente Dick Cheney – il rapporto sulla politica di energia nazionale – enunciava chiaramente due priorità: la diversificazione dei rifornimenti in materia di petrolio e l’acquisizione di riserve supplementari per poter rispondere all’aumento della necessità nel corso dei prossimi 25 anni.
Il Medio Oriente gioca in questa prospettiva un ruolo essenziale, perché le sue riserve (di petrolio) sono le più importanti del mondo e i costi di sfruttamento i meno onerosi. L’Iraq dispone della seconda riserva petrolifera provata al mondo (115 miliardi di barili, dopo l’Arabia Saudita). Secondo alcune stime la cifra sarebbe addirittura di 250 miliardi di barili, perché oltre il 90% del sottosuolo iracheno rimane ad ora inesplorato.

Ma nello sforzo di prendere il controllo del petrolio iracheno, gli Americani mirano anche a un altro obiettivo, più importante ancora del garantirsi i rifornimenti. Questo obiettivo è di controllare le risorse energetiche da cui dipenderanno nei prossimi dieci anni le economie dei principali concorrenti, a cominciare dalla Cina.
L’Asia, malgrado le difficoltà del Giappone, è oggi la regione economicamente più dinamica del mondo. E la Cina, il paese più popolato del mondo, si rivela essere l’unico che possa rivaleggiare con gli Stati Uniti nella prospettiva dei quindici o venti anni a venire. Ma la Cina è anche un paese in gran parte dipendente dal proprio rifornimento di petrolio. La Cina è solo un debole produttore di petrolio. Dal 1993 è importatrice netta. Oggi terzo consumatore di energia al mondo, ha dovuto importare nel 2001 il terzo del proprio consumo di petrolio. Dal 2010 dovrà importare la metà del suo fabbisogno. In queste cifre si sintetizza la posta in gioco.
La guerra in Afganistan ha già permesso agli Stati Uniti di prendere il controllo sul petrolio dell’Asia Centrale e del Mar Caspio, rendendo così più difficile l’accesso per la Cina ad una fonte di rifornimento che non sia quella del Golfo. A lungo termine l’obiettivo degli Americani è di ottenere dai Russi che la loro produzione di petrolio sia convogliata in Occidente, e non in Asia, e di accerchiare la Cina per mezzo di una rete di alleanze con la Russia, l’India, la Corea del Sud, Taiwan e il Giappone. In una tale prospettiva, mettere la mano sul petrolio dell’Iraq, nell’attesa di potersi impossessare di quello dell’Iran, significa darsi i mezzi per un’eventuale asfissia energetica della Cina, cioè di premunirsi contro una possibile ostilità da parte di Pechino. é anche un asso evidente per fare del XXI secolo un secolo americano.
Una tale strategia si è imposta così facilmente presso la Casa Bianca in quanto la maggior parte dei dirigenti americani attuali, a cominciare da George W. Bush e Dick Cheney, appartengono da lunga data alla lobby del petrolio texano, qando non sono, semplicemente, rappresentanti del complesso dell’industria bellica.
Ma questa amministrazione ha anche altre caratteristiche. Rappresenta anche la punta di lancia di una nuova tendenza politico-ideologica che si potrebbe, in mancanza d’altro, denominare la scuola neo-imperialista o neo-egemonista.
Dopo il 1945, l’imperialismo americano si era soprattutto manifestato attraverso istituzioni politiche e giuridiche internazionali. Dopo gli anni ’80, la politica americana si è inoltre caratterizzata di un interventismo economico e commerciale planetario. Oggi all’interventismo economico si aggiunge quello militare che permette agli Stati Uniti di essere presenti ovunque – truppe americane sono oggi insediate in oltre quaranta paesi – e di intervenire a proprio vantaggio in tutte le regioni del globo.
Al tempo dell’elezione di G.W. Bush sono stati proprio i principali rappresentanti di questa scuola neo-imperialista ad arrivare al potere, e cioè: il vice presidente Dick Cheney, il segretario alla difesa Donald Rumsfeld, il suo assistente Paul Wolfowitz, il presidente del consiglio delle politiche della difesa del Pentagono, Richard Perle, senza dimenticare, sul piano intellettuale, personaggi come Robert Kagan, William Kristol e Charles Krauthammer. Il punto comune di questi “falconi” massimalisti è di credere che l’impiego della formidabile macchina di guerra americana sia sempre legittimo quando serve agli interesse dell’America, in quanto sono ritenuti per principio essere conformi alle aspirazioni umane. In questa ottica, una nuova ottica è stata quindi messa a punto. Essa consiste nell’agire con lo scopo principale di rendere perenne l’egemonia attuale, essendo l’obiettivo quello di garantire l’invulnerabilità degli Stati Uniti e di sviluppare la loro capacità di combattere, invadere e sottomettere qualunque potenza ostile, per impedire a ognuna delle potenze rivali di colmare il proprio ritardo rispetto agli Stati Uniti d’America, iniziato dal crollo del sistema sovietico.
Si sa che gli Americani hanno sempre avuto la tendenza a cercare soluzioni militari ai problemi politici e soluzioni tecniche ai problemi militari. Questa tendenza si è oggi esacerbata al punto che la potenza americana sembra essere stata semplicemente ridefinita come pura capacità di annientare.
Parallelamente, e per la prima volta dal XIX secolo, questa esibizione di forza bruta si accompagna di un discorso esplicito di legittimazione dell’egemonismo planetario.
Gli articoli di Robert Kaplan, Charles Krauthammer, Max Boot, Norman Podhoretz, Sebastian Mallamy e tanti altri sono a questo proposito del tutto inequivocabili. Tutti ripetono che l’America gode oggi di un potere di cui nessuna potenza ha mai disposto nella storia e che debba usarla senza reticenze per riorganizzare il mondo sul proprio modello. Tutti sottolineano che gli Stati Uniti debbano emanciparsi da qualunque tutela delle organizzazioni internazionali per agire soli o con delle coalizioni di circostanza, in funzione dei propri esclusivi interessi nazionali, senza mai interrogarsi sulle cause economiche o sociali della violenza alla quale pretendono di rispondere. Tutti affermano che l’America non deve fidarsi di nessun alleato e deve impegnarsi a mantenere l’Europa in una posizione subordinata.
La conseguenza più diretta di questo nuovo modo di vedere è la scalata di un nuovo unilateralismo. Dopo aver tentato di usare a proprio vantaggio le istituzioni internazionali, gli Stati Uniti se ne sono distaccati per farsi unici paladini. Questo unilateralismo consiste nel sottrarsi senza scrupoli agli obblighi del Diritto Internazionale e alle regole della cooperazione multilaterale. Ancora prima dell’elezione di G.W. Bush, il Senato americano si era rifiutato di ratificare il trattato sul divieto delle armi biologiche e chimiche.
Gli Americani hanno anche rifiutato di ratificare il protocollo Kyoto sulla protezione dell’ambiente. Hanno denunciato unilateralmente il trattato ABM sugli armamenti antimissili che univa Mosca e Washington dal 1972. é ancora più clamoroso il fatto che nel maggio 2002 hanno fatto conoscere il proprio rifiuto di riconoscere la legittimità della Corte Penale Internazionale dell’Aia, di cui avevano tuttavia sottoscritto l’atto di creazione. Coscienti che né l’Europa né la Russia possano attualmente colmare il vuoto geopolitico provocato dal crollo del blocco comunista, gli Americani esimono se stessi da qualunque obbligo esterno, manifestando una totale indifferenza per il proprio isolamento crescente sulla scena internazionale.
Parallelamente, per potere “proiettare” la propria potenza in qualunque momento e in qualunque regione del mondo, gli Stati Uniti hanno deciso di dotarsi di mezzi militari senza precedenti. Nel 2003 il budget militare americano ammonterà a circa 380 miliardi di dollari – l’equivalente del PIL globale della Russia! -, che aumenterà di 48 miliardi di dollari rispetto al 2002. Queste spese dovrebbero essere portate a 450 miliardi di dollari nel 2007. Una tale somma è per se stessa superiore al budget militare complessivo della Cina, della Russia, della Francia, della Germania, dell’Inghilterra, di Israele e del Giappone.
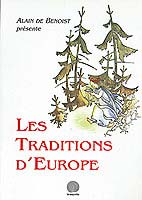
Tutto ciò significa che l’ordine internazionale in vigore fino ad oggi è terminato. Assumendosi, senza reticenze, il ruolo di “gendarme globale”, il governo americano rifiuta di riconoscere ormai le decisioni che vengono prese in merito al Diritto Internazionale, quando le ritiene contrarie ai propri interessi. Si distacca così dalla logica del diritto verso quella della potenza pura.
Le Nazioni Unite, fino ad ora garanti della sicurezza collettiva, sono in questo modo relegate ad un ruolo marginale o ridotte ad un semplice organismo di registrazione sottomesso ai criteri americani.
“Gli Stati Uniti sognano un mondo dove gli altri paesi siano legati da trattati e dove possano definirne razionalmente la politica”, diceva recentemente Pascal Boniface. In ultima analisi, è ad una destabilizzazione generale delle relazioni internazionali che si potrebbe assistere.
Ciò che gli strateghi di Washington chiamano oggi la “guerra contro il terrorismo” sono la prova di questo stesso unilateralismo. Il neo-terrorismo globale viene inteso come una realtà e una minaccia alla quale bisogna rispondere. Il fatto che gli Stati Uniti mettano in guardia contro un fondamentalismo mussulmano che loro stessi non hanno cessato di alimentare quando si trattava di affrontare il nazionalismo laico arabo, non può tuttavia ingannare nessuno. La loro tattica è evidentemente di gonfiare il pericolo, per trarne vantaggio.
Proprio come in passato lo era la “minaccia sovietica”, oggi il sintagma del “terrorismo islamico” funge da operatore di legittimazione di un vero racket politico, da ricatto per la protezione. Il metodo consiste nel far credere che qualunque nemico dell’America sia anche nemico dei suoi alleati, in modo da assicurarsi il sostegno che questi ultimi potrebbero essere tentati di rifiutare.
Parallelamente si fa di tutto per mascherare il fatto che l’islamismo radicale è prima di tutto un fenomeno politico, con obiettivi politici e cause politiche.
Il tema dello “shock delle civiltà” lanciato dal teorico della Trilaterale, Samuel Huntington, ha come principale obiettivo di fare perdurare il dominio americano sul pianeta, mascherando le fratture ben reali che vedono opposti attualmente l’Europa e gli Stati Uniti. “Il tema dello shock delle civiltà – dichiara Aymeric Chauprade – serve oggi gli interessi degli Americani, degli Israeliani e degli Islamici. Tutti giocano sulla logica dei blocchi contro la logica dell’equilibrio delle nazioni. L’America per costruire il blocco transatlantico, Israele per salvare la propria condizione di colonizzatore. Gli Islamici per spezzare le frontiere interne del mondo mussulmano […] Giocando la logica dello shock delle civiltà l’America può vassallizzare agevolmente l’Europa occidentale e la Russia, e progredire verso l’obiettivo di costruzione di un vasto blocco transatlantico da Vancouver a Vladivostok (secondo l’espressione usata da James Baker nel 1991) per fronteggiare l’Islam e la Cina, grandi avversari potenziali nei prossimi 15 anni”.
Tutti sanno bene, in realtà, che il neo-terrorismo islamico nasce principalmente come conseguenza del sostegno apportato dagli Stati Uniti alla repressione brutale della resistenza palestinese – e che è altrettanto una reazione convulsiva ad una globalizzazione pilotata dall’America, intrinsecamente indifferente al mondo storico, alla diversità umana, ai costumi e alle diversità culturali. Come lo ha ben espresso Jean Baudrillard, “la mondializzazione del terrorismo risponde al terrorismo della mondializzazione”. Lottare contro il terrorismo esige quindi prima di tutto che ci si interroghi sulle cause – precisamente ciò che gli Americani non sono disposti a fare, perché ciò li costringerebbe a rimettersi in discussione.
E l’Europa, in tutto questo? E l’Europa che, di fronte alla crisi irachena, è stata come sempre incapace di fare terminare una comune presa di posizione?
L’alternativa davanti alla quale si trova l’Europa è in effetti sempre la stessa: o di dare la priorità alla liberalizzazione, sposando la dinamica di un grande mercato che mira ad allargarsi il più possibile, dando la priorità alla liberalizzazione – e in questo caso l’influenza americana diventerà qui preponderante – oppure di appoggiarsi su una logica di approfondimento delle proprie strutture di integrazione politica sul versante del federalismo e della sussidiarietà in una prospettiva essenzialmente continentale e con l’intenzione di fare da contrappeso agli Stati Uniti.
Per ora, l’Europa attraversa una crisi istituzionale senza precedenti. Non ha né volontà politica né legittimità democratica. Gli Stati che la compongono rifiutano di attribuirle delle reali competenze politiche. Le loro ambizioni di “riforma strutturale” si riducono alla liberalizzazione e al deregolamento, nella priorità data all’apertura dei mercati rispetto alle politiche comuni. L’Europa è lanciata in una fuga in avanti che dà la priorità all’allargamento burocratico piuttosto che al rinforzare le proprie capacità di decisione politica.
Allo stesso tempo l’accento è messo, non sulla definizione di popolo politico, di sovranità, di comunità o di democrazia, ma sui valori commerciali, sul governo astratto e sulla giustizia procedurale. La costruzione europea si fa essenzialmente nell’ambito economico, uno squilibrio intrinsecamente portatore di una deriva liberale che tende a farne una zona commerciale di libero scambio invece di permetterle la possibilità di diventare un polo regolatore della mondializzazione.
L’Unione Europea sarà costituita entro breve da una trentina di paesi. Ora è chiaro che, finché non si sarà costituito un “nucleo compatto”, più numerosi saranno gli Stati membri più sarà difficile per l’Europa giocare un ruolo di contrappeso rispetto agli Stati Uniti. Al vertice di Copenhagen, piuttosto che strutturare e approfondire le proprie istituzioni, l’Europa si è allargata a degli Stati perfettamente docili alla politica americana, che vogliono diventare membri soltanto per potere godere della protezione della NATO, e corre quindi il rischio di ridurre se stessa all’impotenza e alla paralisi. Questi nuovi Stati membri sono stati accettati senza prendersi la pena di interrogarsi sulle frontiere dell’Europa né di intraprendere le riforme istituzionali necessarie.
Per completare il tutto l’Europa ha ora in mente di integrare anche la Turchia, in altre parole di fare entrare nell’Unione Europea un paese che per via del suo peso demografico, ne diventerebbe lo Stato membro più influente in termini di voti. Questo progetto di integrazione della Turchia, che ha già ricevuto l’appoggio esplicito di Jacques Chirac, Tony Blair e Silvio Berlusconi, risponde al desiderio degli Americani, che sognano di costruire un blocco occidentale sotto la propria egemonia, con la Turchia e Israele come teste di ponte in Medio Oriente.
Tutto ciò non è poi proprio nuovo. Ciò che è nuovo, per contro, è l’opposizione crescente che suscita ovunque nel mondo la nuova politica americana. Un vasto sondaggio realizzato dal Pew Research Center di Washington su 38.000 persone ripartite sui cinque continenti, che è stato pubblicato all’inizio di dicembre 2002, ne è testimone eloquente. Dopo l’anno 2000, data del precedente sondaggio, la quota di popolarità degli Stati Uniti si è nettamente abbassata in 20 paesi su 27.
In un lungo testo che ha avuto forte risonanza, Robert Kagan ha opposto, qualche mese fa, un’Europa che vivrebbe nella speranza kantiana di una sorte di “pace perpetua” e non avrebbe alcun desiderio di uscire da uno stato di debolezza di cui avrebbe fatto il proprio ideale, contro un’America “realista”, cosciente della realtà hobbesiana del mondo – la guerra di tutti contro tutti – e ben decisa ad assumersi le responsabilità planetarie con tutti i mezzi.
La conclusione di questo articolo è rivelatrice “é tempo – scriveva Rober Kagan – di smettere di fare finta che gli Europei e gli Americani condividano una stessa visione del mondo, o perfino che abitino nello stesso mondo […] Su tutte le questioni essenziali relative al potere, le prospettive europee e americane divergono […] Sulle principali questioni strategiche internazionali, gli Americani vengono da Marte e gli Europei da Venere. Sono d’accordo su poche cose e si comprendono sempre meno. Questo stato delle cose non ha niente di provvisorio […] Le ragioni della frattura transatlantica sono profonde, vengono da lontano e sono destinate a perdurare […] Gli Stati Uniti e l’Europa hanno [ormai] preso delle direzioni differenti”.
In un discorso rimasto celebre, G.W. Bush si era chiesto come fosse possibile non amare l’America. La risposta che lui stesso diede a questa domanda (“Noi sappiamo quanto siamo bravi!”) era che ciò che si rimprovera agli Stati Uniti, non sono i suoi difetti, perché non sarebbe capace di averne, ma le loro qualità – ciò che porta a considerare tutti i critici come altrettanti malati, criminali o perversi. Da ciò è evidente quanto G.W. Bush e Usama Ben Laden vedano entrambi il mondo in Bianco e Nero. Bush e Ben Laden appartengono allo stesso mondo, quello del nemico assoluto, del Bene e del Male assoluti, della mobilitazione totale in nome di una divinità unica, in nome dell’ideologia dello Stesso. Bush parla di crociate, come Ben Laden parla di “jiad”: l’uno e l’altro vogliono condurre una “guerra santa” contro gli “infedeli” che non condividono il loro modo di vedere. I miscredenti devono essere convertiti o altrimenti distrutti.
Basata sull’idea di un “destino manifesto” (manifest destiny), “la politica estera degli Stati Uniti si è sempre basata sulla convinzione che la modernizzazione, l’occidentalismo e l’americanizzazione sono dei benefici intrinseci, perché alla fine il destino di tutte le nazioni consiste nell’adottare il modello americano. Indispensabili all’instaurazione di un ordine che soddisfi la società […]
L’Unione Sovietica aveva dei “satelliti”, l’America oggi ha dei vassalli. Gli Stati Uniti credono che possano contemporaneamente dominare gli altri paesi ed anche allearsi con loro. Il loro concetto di alleanza è un concetto dove l’America cucina, mentre gli Europei lavano i piatti. Ma gli Stati Uniti non sono – più di quanto non lo sia la Turchia – una potenza europea. I loro interessi sono diversi – e il loro modo di difenderli differisce dal nostro.
Questa idea che gli Stati Uniti abbiano per missione di aprire la strada all’umanità, questa idea che il mondo finirà per integrarsi ad un modello unico, la cui superiorità non potrebbe essere contestata da nessuno, questa idea che i valori politici e le norme morali americane debbano essere adottati da tutti e ciascuno – i recalcitranti assimilati ad un “asse del male” che deve essere sradicato con tutti i mezzi – ecco precisamente ciò che non si può ammettere. Spero di tutto cuore che gli Europei non lo ammetteranno.





